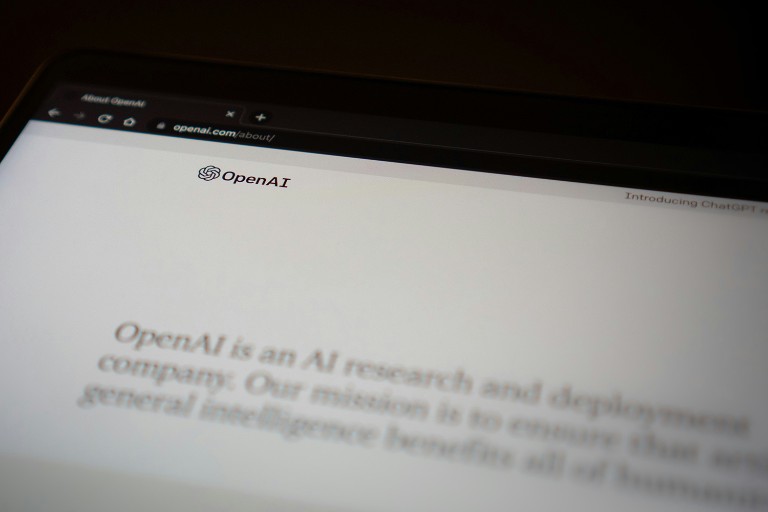Il DanteGPT di Primo Levi
Già negli anni Sessanta Primo Levi immaginava uno strumento simile a ChatGPT: il “versificatore”, capace di scrivere poesie attraverso algoritmi.
Nasce prima l’arte (la creatività) oppure la tecnologia (l’invenzione)? A sfogliare i libri sembra esserci una prima risposta. Nel 1966 uscivano per Einaudi le Storie naturali di uno scrittore sconosciuto, Damiano Malabaila. Un primo indizio lo avremmo avuto se la presentazione della quarta di copertina fosse stata firmata: in questo caso avremmo letto “Italo Calvino”, che curava i racconti per Einaudi. Malabaila era uno pseudonimo di Primo Levi, scrittore già affermato per Se questo è un uomo. Dopo l’esperienza della pubblicazione del libro sulla sua detenzione nei lager, Levi era tornato al suo “mestiere”, che era fare il chimico. Ed è un po’ il Levi scienziato che qui ci interessa. Nel racconto Il versificatore Levi descriveva una macchina che scriveva poesie: un “versificatore” capace di generare versi attraverso calcoli e combinazioni di parole. Come se la scrittura fosse il risultato di un algoritmo. Non era semplicemente un robot che produceva rime, ma un’intelligenza artificiale che cercava di emulare un atto umano, di penetrare il mistero del linguaggio e della creazione artistica. Levi non si limitava a descrivere la macchina, ma ne tracciava il contorno metafisico: la sua capacità di produrre poesia, pur essendo basata su algoritmi, lasciava intatta la domanda centrale: può una macchina sostituire davvero l’essere umano nella creazione di significato?
Quella macchina, che nel contesto del racconto era un esperimento di ingegneria del pensiero, sembrava un passo futuristico verso una realtà che oggi riconosciamo nella potenza delle intelligenze artificiali, come ChatGPT. Se Levi avesse vissuto abbastanza a lungo per vedere un mondo in cui algoritmi complessi come questi rispondono alle domande, scrivono racconti e persino generano poesia, forse avrebbe visto il “versificatore” non come una mera curiosità tecnologica venduta dal Signor Simpson – caricatura del venditore di una fantasmagorica società americana – ma come un inizio di una nuova era in cui la tecnologia, pur sembrando creativa, rimane comunque un riflesso della mente umana.
È come se in un angolo appartato della sua biblioteca, Levi si fosse seduto davanti a un computer moderno, stupito dall’efficienza di un programma capace di rispondere a qualsiasi domanda, di scrivere sonetti, di analizzare e generare nuove forme di espressione. Come se avesse guardato in uno specchio temporale la vetrina di una macchina che, come il suo versificatore, possedeva una strana autonomia. Ma mentre digitava le sue richieste, pensava a una domanda più profonda: «Cosa significa essere “creativi” in un mondo dove anche una macchina, privata della sua umanità, riesce a produrre qualcosa di simile a un’opera d’arte?»
Forse il versificatore di Levi non era solo una macchina che scriveva, ma anche una metafora. Simboleggiava il nostro desiderio di penetrare il mistero della mente, di comprendere il modo in cui l’arte nasce e, al contempo, il nostro timore di essere superati dalla tecnologia. Siamo negli anni Sessanta, nel pieno boom della tecnologia da ufficio: le scrivanie si riempiono di calcolatrici futuribili della Olivetti, sui giornali si parla di mainframe che nessuno ha visto e di cibernetica, la nuova scienza. L’intelligenza artificiale è nata in realtà da pochi anni. Dunque già esiste nelle sue componenti essenziali. Alan Turing si è già posto la domanda del secolo: le macchine possono pensare? Ecco allora che l’estro creativo di Levi, in una mente naturalmente portata alla curiosità scientifica, produce la “DanteGPT” ante litteram, la macchina capace di versificare. Insomma, bisogna stare attenti a rispondere troppo frettolosamente alla domanda su creatività e invenzione.
Il testo resta da leggere. Come resta da ricordare il monito del poeta (nella realizzazione Rai, l’indimenticabile Gianrico Tedeschi) alla sua segretaria: «Non metta su codesto broncio, signorina, e non si cacci in capo idee sbagliate. (Suadente) Non si può restare indietro, lei lo capisce benissimo. Bisogna tenere il passo coi tempi. Dispiace anche a me, glielo assicuro, ma a un certo punto bisogna pure decidersi. Del resto, non abbia preoccupazioni: il lavoro per lei non mancherà mai. Ricorda, tre anni fa, quando abbiamo comperato la fatturatrice? [...] Ebbene: come si trova oggi? Ne potrebbe fare a meno? No, non è vero? È uno strumento di lavoro come un altro, come il telefono, come il ciclostile. Il fattore umano è e sarà sempre indispensabile, nel nostro lavoro; ma abbiamo dei concorrenti, e perciò dobbiamo pure affidare alle macchine i compiti più ingrati, più faticosi. I compiti meccanici, appunto…». Appunto.
Categoria: Tecnologia
Titolo: Il DanteGPT di Primo Levi
Autore: Massimo Sideri